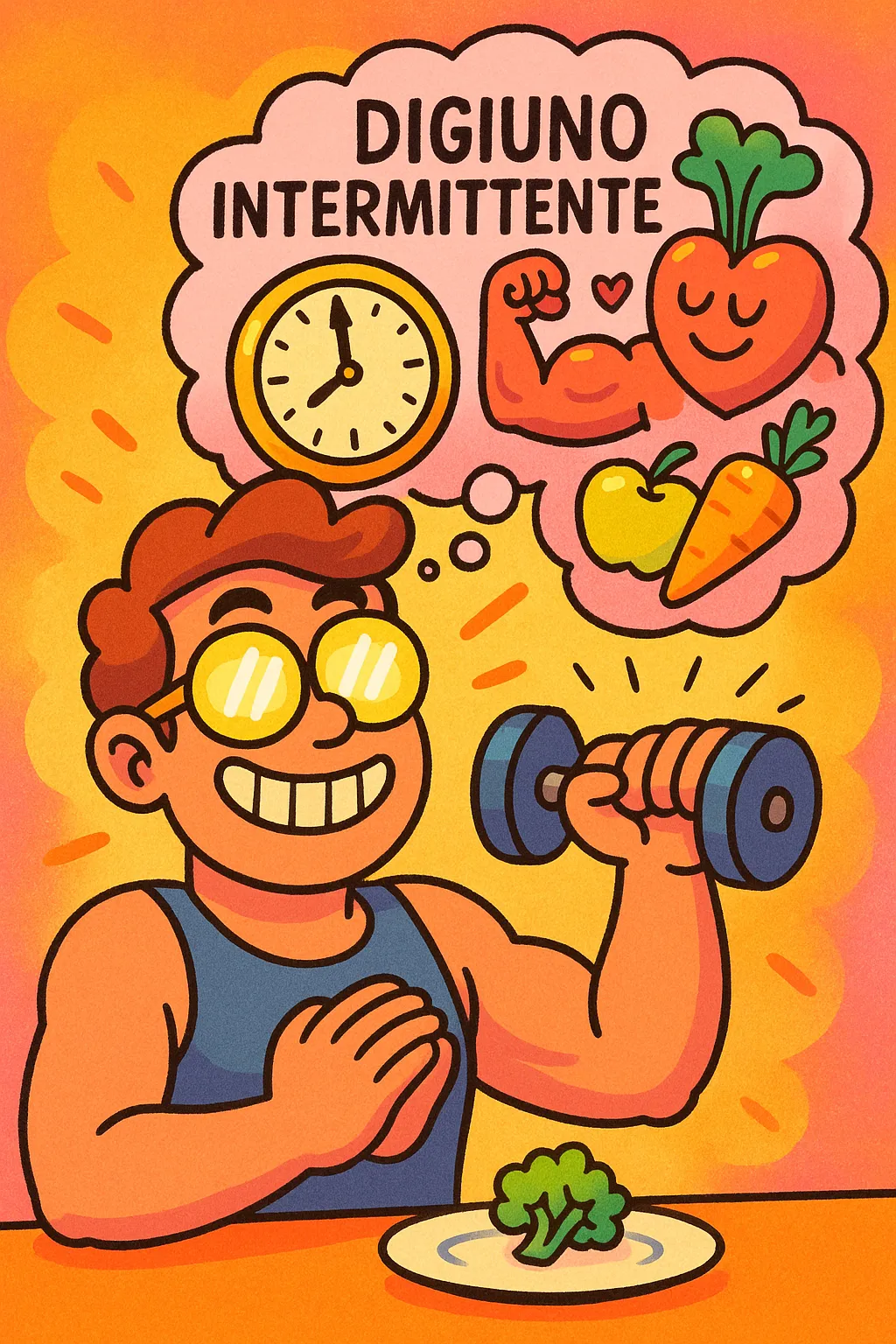
Negli ultimi anni il digiuno intermittente (intermittent fasting, IF) è passato da tendenza di nicchia a strategia sempre più citata anche in ambito medico. Ma quanto è davvero efficace per la salute? Fa bene a tutti? È meglio delle diete ipocaloriche classiche?
Spoiler: può essere utile, ma non fa miracoli, e non è adatto a tutti. Vediamo cosa dice la scienza seria.
Le meta-analisi e gli studi clinici randomizzati (RCT) più recenti dicono chiaramente una cosa: il digiuno intermittente fa dimagrire quanto la restrizione calorica continua (quella classica: meno calorie ogni giorno). Nessuna superiorità netta, ma può essere utile per chi lo trova più facile da seguire.
In un RCT durato 12 mesi, ad esempio, la strategia del 4:3 (tre giorni a settimana con dieta molto ipocalorica) ha portato a una perdita di peso leggermente maggiore rispetto a una dieta ipocalorica tradizionale. Un vantaggio, sì, ma non rivoluzionario.
Ci sono anche dati incoraggianti su glicemia e sindrome metabolica. In uno studio su adulti con sindrome metabolica, concentrare i pasti in una finestra di 8–10 ore per 3 mesi ha migliorato l’emoglobina glicata (HbA1c) di circa 0,10%. Un effetto piccolo, ma reale.
Per quanto riguarda pressione, lipidi e infiammazione, gli effetti sembrano più legati alla perdita di peso complessiva che alla struttura del digiuno in sé. In altre parole: non è il digiuno che cura, è il fatto che mangi meno e meglio.
Molti parlano dei possibili effetti del digiuno su longevità e autofagia (il “riciclo” cellulare). In effetti, gli studi sugli animali mostrano risultati impressionanti: topi che vivono più a lungo, cellule che si rinnovano meglio, infiammazione che si riduce.
Ma negli esseri umani mancano ancora prove solide. Una celebre review pubblicata sul New England Journal of Medicine ha spiegato bene i meccanismi biologici, ma ha anche sottolineato che servono studi clinici con esiti “forti” (infarti, mortalità, ecc.) per poter trarre conclusioni certe.
a) Fai fatica a seguire una dieta ipocalorica tradizionale;
b) Preferisci mangiare in finestre ristrette (es. 8:00–16:00);
c) Hai uno stile di vita regolare e vuoi una struttura semplice da mantenere;
d) Cerchi un modo per migliorare la consapevolezza alimentare.
1) Hai diabete in terapia (soprattutto con insulina o sulfoniluree): serve una valutazione medica e un aggiustamento dei farmaci;
2) Sei in gravidanza o allattamento;
3) Hai una storia di disturbi del comportamento alimentare;
4) Sei sottopeso o molto fragile;
5) Hai litiasi biliare o vuoi iniziare una dieta molto restrittiva senza supervisione: il rischio di calcoli alla colecisti aumenta con dimagrimenti rapidi.
I più segnalati nei primi giorni (e a volte anche oltre) sono:
In chi soffre di emicrania, il digiuno può anche diventare un trigger. Quindi meglio parlarne col medico prima di iniziare.
Se ti incuriosisce e vuoi testarlo, scegli un protocollo che riesci a mantenere, senza ossessioni. Le strategie più semplici e promettenti sono quelle di “time-restricted eating” con finestre precoce: ad esempio mangiare tra le 8:00 e le 16:00, e poi digiunare fino al giorno dopo.
Nel frattempo:
Il digiuno intermittente non è magico, ma può essere uno strumento utile, se ti aiuta a mangiare meglio, meno, e con costanza.
La chiave non è quando mangi, ma cosa e quanto. E soprattutto: se riesci a mantenerlo nel tempo.
Parlane sempre con un professionista se hai patologie o assumi farmaci: il fai-da-te non è mai una buona idea, nemmeno se va di moda su TikTok.
No, gli studi mostrano che la perdita di peso è simile a quella delle diete ipocaloriche tradizionali. Il vantaggio è soprattutto pratico: alcune persone lo trovano più facile da seguire.
Può migliorare leggermente glicemia e sensibilità insulinica, ma gli effetti su pressione, lipidi e infiammazione dipendono più dalla perdita di peso generale che dal digiuno in sé.
No. Non è consigliato in gravidanza, allattamento, disturbi del comportamento alimentare, diabete in terapia insulinica o soggetti molto fragili. In questi casi serve sempre la supervisione di un medic